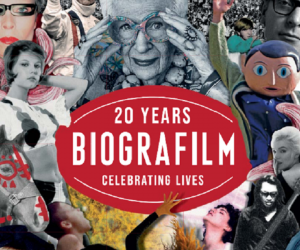Venezia 74. Downsizing e altre recensioni
Matt Damon protagonista a Venezia 74 con Downsizing e Suburbicon
Matt Damon, col suo faccione rassicurante da buon americano, è protagonista di due tra le opere hollywoodiane più attese di Venezia 74, entrambe presentate in Concorso: il film d’apertura Downsizing, diretto da Alexander Payne, e la nuova regia di George Clooney, Suburbicon, tratto da una sceneggiatura dei fratelli Coen.

Downsizing parte da un incipit fantascientifico con risvolti di impegno sociale – alcuni scienziati scoprono il modo di ridurre le dimensioni di un essere umano fino all’altezza di pochi centimetri, con relativa diminuzione del costo della vita, per salvare il pianeta dalla sovrappopolazione – concentrandosi da subito sulla vicenda individuale di Paul (Damon), un fisioterapista aziendale che decide di sottoporsi al trattamento di miniaturizzazione per migliorare la propria condizione umana ed economica. Nonostante le grandi potenzialità del soggetto, Payne trasforma quello che sarebbe potuto essere sia una solida epopea di fantascienza adulta, sia un apologo grottesco sulla riduzione del valore della vita umana, in un fragile e poco ispirato road movie che ripropone il tema del viaggio come occasione di crescita personale e di riflessione sulle priorità già ampiamente affrontato, e con risultati decisamente migliori, in molte sue opere precedenti, da A proposito di Schmidt a Sideways, fino a Nebraska. Ne risulta quindi un film debole, con spunti umoristici un po’ forzati (nonostante un Christoph Waltz in buona forma gigionesca nei panni di un trafficante slavo) e un messaggio ecologista – affidato alla giovane attivista asiatica impersonata dalla pur brava Hong Chau – fin troppo invadente. Un’opera dalle molte anime, ma priva di un’identità convincente.
Suburbicon prende invece il titolo da una fittizia cittadina statunitense degli anni ’50, in cui tutto sembra perfetto. L’arrivo di una famiglia di colore, vista dalla comunità come un elemento di disturbo e da subito osteggiata, fa da sfondo alle disavventure del piccolo Nicky, un bambino che scopre traumaticamente l’esistenza della violenza. Adattando una sceneggiatura dei fratelli Coen del 1986, Clooney sceglie nuovamente un’ambientazione nel passato per affrontare problematiche sociali contemporanee: in questo caso, il pregiudizio razziale che scarica sulle minoranze la responsabilità di ogni crimine, ignorando il marcio che si annida dietro la facciata perbene di famiglie rigorosamente bianche. Le caratterizzazioni sono abbastanza divertenti e tipicamente coeniane – dal padre di famiglia (Damon) pieno di scheletri nell’armadio alla coppia di assassini feroci quanto inetti, fino alle gemelle (madre e zia di Nicky) impersonate da Julianne Moore – anche se il cinismo grottesco dei due fratelli appare mitigato dall’idealismo di Clooney. L’ambientazione anni ’50 e la vicenda collaterale della famiglia afroamericana risultano però poco incisive, privando in parte di efficacia il sottotesto di denuncia dell’America trumpiana. Al contrario si rivela felice la scelta del punto di vista di un bambino (l’unico, nella sua innocenza, immune al pregiudizio), che regala alla vicenda connotazioni da fiaba nera, a tratti ascrivibile nel filone home invasion, ma alleggerita da sprazzi di umorismo nero, dando vita a un’opera magari non originalissima né all’altezza delle sue ambizioni, ma piacevole e ben raccontata.