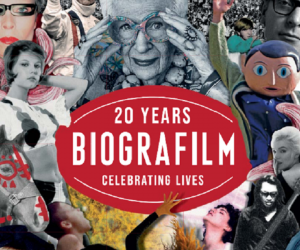Berlinale 2014: Black Hole, Thin Ice e altre recensioni
La sessantaquattresima edizione della Berlinale si è chiusa con L’Orso d’oro vinto dal noir d’atmosfera cinese Black Hole, Thin Ice di Diao Ynan, che alla vigilia non era nell’elenco dei favoriti, e la cui vittoria ha colto di sorpresa molti. In un concorso ufficiale che, a detta di quasi tutti, non ha entusiasmato per qualità media dei film proposti, è stato premiato un film di genere sicuramente riuscito, ma anche non particolarmente entusiasmante né particolarmente originale o innovativo, che nulla toglie e poco aggiunge al genere di riferimento. La discesa all’inferno e la risalita vissuta dal poliziotto protagonista – interpretato da Liao Fan, vincitore dell’Orso d’argento per la miglior interpretazione maschile – è sorretta da atmosfere cupe e iperrealiste, da picchi di violenza esplicita alternati a squarci d’ironia e da un’evoluzione del personaggio molto “classica”, che prende un po’ dalla tradizione del noir occidentale e un po’ dalle caratteristiche più autoctone del cinema orientale. La visione è quindi sicuramente piacevole, e il film è interessante e coinvolgente, ma allo stesso tempo anche del tutto “medio”: forse un po’ poco per giustificare la vittoria in un festival di primo livello come quello di Berlino.
In un concorso che, come accennato, ha offerto poche perle, una delle delusioni più cocenti è stato Aloft della peruviana Claudia Llosa (già vincitrice dell’Orso nel 2009), al suo esordio americano, con a disposizione nomi del calibro di Jennifer Connelly, Mélanie Laurent e Cilian Murphy. Il film racconta di rapporti incompresi e smarriti, di solitudini e asperità caratteriali, di tragedie, di sensi di colpa e di responsabilità negate troppo a lungo, in una cornice stracolma di stereotipi, visivi e narrativi, tipici del dramma “indie style”. Non bastano a salvare dalla prolissità in agguato già poco dopo l’inizio la fotografia, che si concentra sugli inserti paesaggistici e panoramici, e le espressioni intense degli attori. Il film è banale e risaputo nella rappresentazione dei sentimenti e nel racconto dell’evoluzione dei personaggi e, senza girare troppo intorno alla ricerca di eufemismi che ingentiliscono, annoia parecchio.
Una delle anteprime più attese, pure questa accolta da commenti perlopiù negativi, e anche da qualche risata durante la proiezione stampa, è stata La bella e la bestia di Christophe Gans. La trasposizione cinematografica francese (in attesa di quella hollywoodiana) della celebre fiaba, in realtà, non è così deludente come sembra, almeno per quanto riguarda la prima parte. A differenza delle traduzioni filmiche di fiabe importanti degli ultimi anni, l’operazione di Gans cerca di essere più filologica a livello iconografico: la fotografia e le scenografie ricordano infatti, citandole anche esplicitamente, la filigrana e l’atmosfera di magia tipica delle illustrazioni delle raccolte di fiabe, senza dimenticare di arricchire l’impianto visivo con citazioni, oltreché cinematografiche, della pittura soprattutto del XIX Secolo, da Friedrich agli impressionisti, ai Preraffaeliti. Se a livello visivo il film funziona, convince meno a livello di partecipazione emotiva, e cade clamorosamente nell’ultima parte, dove la pacchianeria e il gigantismo estetico fine a sé stesso, prima perlopiù evitati, ricompaiono mostrando gli interessi e rovinando un film fino a quel momento non da buttare via. Gans appare, purtroppo, quindi più vicino a Silent Hill che a il patto dei lupi, mostrandosi più attento all’impatto visivo fine a sé stesso che alle sue connotazioni emotive e narrative. Se l’intensità del volto di Vincent Cassel, quasi sempre ricoperto dalla chioma leonina, si vede poco, Léa Seydoux si conferma una presenza magnetica.
Tra le altri visioni, il nostro Gianni Amelio con Felice chi è diverso, presentato nella sezione “Panorama documentari”, regala un pregnante, a livello storiografico tanto quanto a livello di partecipazione, documentario sulla condizione degli omosessuali nel recente passato novecentesco del nostro Paese. Tra testimonianze, di gente comune come di celebrità, e grotteschi documenti di repertorio da stampa e tv, la storia dell’omofobia strisciante nella cultura e nelle istituzioni del nostro paese emerge in tutta la sua drammaticità, e quasi palpabile diventa il peso della sofferenza subito dagli intervistati. Amelio ha anche il merito di non aver realizzato un semplice pamphlet monodimensionale nella polemica e nelle prese di posizione, raccontando con chiarezza anche i travagli, i dubbi, i problemi e le sofferenze degli intervistati. Ne esce così un ricco, stratificato e toccante inno alla diversità, che si spera avrà una decente circolazione nelle nostre sale.
Continua a errare su Facebook e Twitter per essere sempre aggiornato sulle recensioni e gli articoli del sito.
Scritto da Edoardo Peretti.