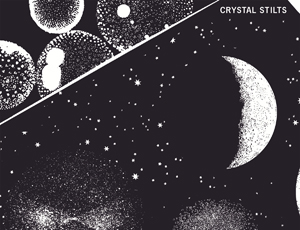AltrodiBlogger Erranti,30 Maggio 2011
Crystal Stilts – In love with oblivion: la recensione
Premetto che, dovendo parlare dei Crystal Stilts, non riesco proprio ad essere obbiettivo. Atteso dal sottoscritto oltre ogni ragionevole misura, il secondo lavoro sulla lunga distanza della band di Brooklyn mantiene le aspettative generate dal primo ep e dall’album d’esordio, sbaragliando il campo da qualsiasi gruppo di emul-rock senza sostanza.
Perché, sì, il sound di riferimento è proprio -e sempre- quello: i Velvet Underground ed il malato immaginario nuovayorkese uniti ad un gusto sciugheiz albionico (ovviamente Jesus and Mary Chain). Il fatto, però, che questo disco non sia una fotocopia del predecessore, la dice lunga sulla distanza che oggi corre tra i Nostri ed i tanti imitatori dell’epoca d’oro del r’n’r alternativo (i mid 60s come gli anni 80). Ferma restando la riconoscibilità della proposta, qui, rispetto al recente passato, si smussano certi spigoli e ci si orienta anche verso altri modelli, siano essi il garage di nuggetsiana memoria o certi motivetti usciti, non si sa come, dall’organo di Ray Manzarek.
Il nuovo circo psichedelico si apre, infatti, sulle note tipicamente doorsiane di “Sycamore tree” senza scordarsi di invitare i Pink Floyd ad un’acida jam da domenica pomeriggio. La giostra continua con l’andamento sbarazzino di “Through the floor” e la byrdsiana “Silver sun”, impennando poi decisamente a metà percorso, laddove “Half a moon” è nuovo trip sonoro di un’estate spesa in qualche garage della suburbia americana a sognare il palcoscenico dell’Ed Sullivan Show.
Di fronte a “Shake the shackles”, singolo-principe di questo lp, è impossibile rimanere inerti: il suo jingle-jangle è pura ribellione che sale dalla pancia del disilluso, a regalare, forse, un fugace momento di riscatto. I Barbarians (ma si potrebbero citare centinaia di altri gruppi misconosciuti) di “Precarious stair” scivolano, poi, nel dark yè-yè del nuovo millennio di “Invisible city” e nel psych di “Blood barons”, dove si odono echi di viaggi interstellari mentre Emily gioca. La chiusa è pura ortodossia velvettiana, con “Prometheus at large” che pare trasfigurarsi nella celebre Run run run di Lou Reed e soci.
Lavoro in grado di mietere consensi tanto tra poseurs modaioli e critici integerrimi, In love with oblivion è un pugno nello stomaco di chi crede non si possa più fare musica decente avendo ascoltato e abusato di certi dischi-sancta-sanctorum.
Abbracciate anche voi il lato oscuro della forza, e tutto sarà più splendente.
![]()
Scritto da Fabio Plodari.
Continua a errare su Facebook e Twitter per essere sempre aggiornato sulle recensioni e gli articoli del sito.