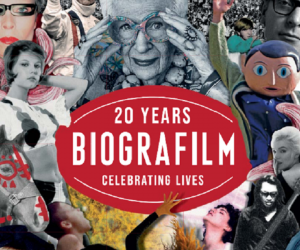El botón de nácar: la recensione

Con il toccante e suggestivo El botón de nácar (Il bottone di madreperla), il Maestro cileno Patricio Guzmán si aggiudica il premio Best Film Unipol Award del Biografilm Festival 2015, che va ad aggiungersi all’Orso d’Argento per la sceneggiatura conquistato alla Berlinale 2015 e ai riconoscimenti per i lavori precedenti (fra gli altri, l’European Film Academy Award 2010 come Miglior Documentario per Nostalgia de la Luz).
Come già quest’ultimo, El botón de nácar esplora le pagine più nere della storia cilena (tema caro al regista, che per la sua cinematografia di denuncia è stato detenuto nello stadio di Santiago dopo il golpe di Pinochet e poi costretto a lasciare il paese) attraverso l’uso degli elementi e di una costante giustapposizione di prospettive fra microcosmi infinitesimali come una goccia d’acqua e macrocosmi infiniti come l’universo stesso. Le sabbie roventi del deserto di Atacama lasciano però spazio alla cerulea maestosità della Patagonia, terra di ghiacci e della ventina di indigeni sopravvissuti allo sterminio da parte dei conquistadores britannici.
All’acqua Guzmán rivolge i suoi numerosi interrogativi esistenziali in un voice-over dai toni elegiaci da cui traboccano amore profondo per il paese e dolore acuto per le atrocità della Storia. L’acqua dà vita, assorbendo l’energia delle stelle; governa il piccolo e il terreno, dalla singola goccia al miracolo del corpo umano, e proietta nell’infinito del cosmo, offrendosi non solo alla Terra, ma anche ad altri corpi celesti; infine, l’acqua ricorda, restituendo memorie di popolazioni e persone desaparecidas.
Partendo dal bottone del titolo, incastrato in un pezzo di rotaia sul fondo del mare, e da un altro leggendario bottone, con cui i conquistadores acquistarono l’indigeno fuegino poi ribattezzato Jemmy Button, Guzmán si chiede perché il Cile non abbia saputo sfruttare la sua lunghissima costa e l’armonia perfetta che gli indigeni avevano costruito con l’acqua. La risposta è nel fil rouge di oppressione e repressione che porta dallo sterminio degli indigeni ai crimini della dittatura di Pinochet; un collegamento che ad alcuni è parso forzato, ma che in realtà non fa altro che raccontare due facce della stessa paura del diverso e dello stesso processo di obliterazione identitaria che accomuna i due grandi momenti bui del Cile, ma anche tante altre forme di violenza perpetrate in ogni parte del mondo.
Guzmán miscela sapientemente la precisione e l’oggettività del documentario con il proprio lirismo innato, coinvolgente e avvolgente, riuscendo al contempo a far luce sul genocidio degli indigeni (illuminanti e intense le testimonianze dei pochissimi discendenti, soprattutto quella della kawashkar Gabriela, che insegna alcune parole nella sua lingua per poi bloccarsi sull’intraducibile “Dios”) e a sublimare la crudeltà in un trionfo di immagini mozzafiato con connotazioni alla Malick che seducono e costringono a riflettere sul rapporto fra l’uomo, la sua terra e l’intero universo.
| Alice C. | ||
| 9 |