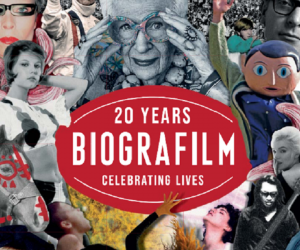Detour. El Rayo: la recensione
A prima vista, El Rayo di Fran Araujo – in concorso al Detour Film Festival – può sembrare una versione mediterranea di Una storia vera di David Lynch, di cui ripropone, come tema portante, il lungo viaggio di un uomo non più giovane, a bordo di un mezzo agricolo, attraverso le campagne di quasi un intero paese. Le analogie non finiscono qui, dato che la testardaggine del protagonista ricorda da vicino quella del vecchio contadino impersonato allora da Richard Farnsworth, così come il campionario di volti umani che incontra e lo aiuta nelle varie tappe del suo viaggio rappresenta ancora un mondo lontano dalla città e in parte legato a certi valori di solidarietà altrove perduti, mentre diversa, benché anche qui legata alla famiglia, ne è la meta.
In questo caso, a salire sul trattore, che viene battezzato El Rayo (il raggio), è il magrebino Hassan, il quale, dopo tredici anni trascorsi come bracciante in Spagna, perde il lavoro e decide di ritornare in Marocco, investendo tutti i suoi risparmi in quel macchinario di seconda mano che avrebbe potuto dare alla sua famiglia un nuovo e più tecnologico mezzo di sostentamento anche nel villaggio natio.
Sul piano della regia, il film è girato con uno stile quasi documentaristico, con un’apprezzabile fotografia dai colori vividi che ritrae il paesaggio collinare spagnolo in tutta la sua bellezza un po’ malinconica, affidandosi invece alla macchina a mano per le riprese in interni, in cui si indugia, a volte, in dettagli visivi evitabili (la macellazione halal) che stonano in parte con il tono pacato e serafico della narrazione. Ma è dal punto di vista della sceneggiatura che El Rayo dimostra tutti i suoi limiti: se risulta assai interessante la riflessione iniziale sulle conseguenze della crisi economica anche in Europa (ormai non più vista come terra delle opportunità), tali da spingere un emigrante come Hassan a tornare in patria, nel suo sviluppo la vicenda non riesce ad appassionare. La linearità che aveva reso grande Una storia vera, qui rischia di diventare piattezza: difficilmente scatta l’empatia con l’imperturbabile protagonista (la cui caratterizzazione non viene approfondita nell’arco dell’intero film), né ci si immedesima più di tanto nelle sue traversie, dato che tutto sembra narrato con eccessivo distacco emotivo, quasi con indifferenza. Non viene sviluppato a dovere il discorso sulla lentezza come scelta di viaggio, né si sviluppa una vera e propria connessione con l’ambiente, inoltre i personaggi secondari mancano di quel calore umano che avrebbero dovuto trasmettere (tranne, in parte, l’artigiano in pensione che ospita Hassan) e la storia si trascina un po’ stancamente, nella sua freddezza, fino a un finale abbastanza scontato, con tanto di musica araba di sottofondo. Non un’opera totalmente da bocciare, ma il modello di riferimento lynchiano aveva ben altra forza emotiva e ben altra caratura cinematografica.
![]()
Continua a errare su Facebook e Twitter per essere sempre aggiornato sulle recensioni e gli articoli del sito.