La Casa (2013): la recensione
Da groovy a not so groovy il passo è breve (se non ti segano le gambe)
Che La Casa di Fede Alvarez non fosse La Casa di Sam Raimi era ben chiaro a tutti, ancora prima dell’uscita nelle sale. Dell’originale condivide l’ambientazione (anche se con significative differenze), l’eterogeneo quintetto di personaggi, la spettacolarizzazione dell’orrore, l’idea di film horror come laboratorio di esperimenti visivi e una certa artigianalità nella realizzazione. Certo, l’artigianalità di Raimi era quella di un progetto che compensava la risicatezza del budget con una straordinaria originalità creativa e con la sperimentazione continua di nuove soluzioni linguistiche, efficacissime sia per l’impatto visivo, sia per la funzionalità nella narrazione. L’artigianalità di Alvarez sta sì nella scelta di evitare qualsiasi tipo di effetto digitale – che, come osserva giustamente il regista, cozza con ogni pretesa di sospensione d’incredulità – ma può comunque contare su 17 milioni di budget. Non male per un esordiente, forte del successo del corto Panic Attack (costo totale: 300$) e contattato da Raimi stesso, qui produttore e supervisore, per la realizzazione del film.
La trama è ben nota. Cinque ragazzi, una casa nel bosco, il ritrovamento di un libro misterioso, la sventurata lettura di alcune formule rituali, il risveglio del demone, la possessione dell’elemento più debole del gruppo, in questo caso Mia, la ragazza tossicodipendente allontanatasi dalla città nel tentativo di porre fine alla sua dipendenza. Ma laddove La Casa di Raimi si caratterizza come un classico dell’orrore anni ’80, La casa di Alvarez è invece rappresentazione plastica del suo tempo, nel radicalizzare alcune caratteristiche dell’originale e nell’allontanarsene per molti aspetti. Innanzitutto, la rappresentazione della mostruosità e dell’osceno come strategia centrale del film, una rappresentazione esplicita, ridondante, compiaciuta, che non rimanda ad altro che a se stessa. In questo, maestro e allievo sono vicini, entrambi decisi a ricreare una blood feast senza precedenti, passando in rassegna tutte le situazioni e gli espedienti più raccapriccianti possibili. Alvarez, con più di trecento litri di fluidi vari a disposizione e tanto entusiasmo, ha gioco facile: si passa così tra aghi conficcati ed estratti a mani nude dagli occhi, arti amputati con coltelli elettrici per arrosto, lingue biforcute dopo un lento passaggio sul filo di lama, volti sfigurati dalla sparachiodi etc. Un orrore giocato tutto sul make-up, sul primissimo piano e sul dettaglio, sui movimenti innaturali che caratterizzano l’essere demoniaco, corpo svuotato di ogni umanità, anatomia trasfigurata, mutilata e dilaniata. E questo Alvarez lo sa fare e anche bene. Ma c’è un’illustre assente a questa festa. E si chiama tensione.
Alvarez, infatti, nel radicalizzare gli aspetti più gore del genere e l’idea di una scansione ritmica sempre più incalzante, sembra smarrire del tutto i più basilari principi del cinema del terrore che, certo, nel moderno cinema horror vengono fortemente ridimensionati di fronte alla necessità sempre più pressante di mostrare piuttosto che alludere, ma restano comunque fondamentali per attivare il meccanismo della paura. Ne La Casa non c’è letteralmente un momento di tregua: il commento sonoro è martellante e invasivo oltre gli standard del genere; il fuori campo non è mai usato per dare un senso di mistero o di attesa quanto per registrare il terrore del personaggio o l’effetto di uno smembramento in atto, ma sempre e comunque di qualcosa che allo spettatore è già stato ampiamente mostrato; manca totalmente il più classico meccanismo della suspense, il colpo di scena disatteso, che dà dinamismo alla climax del racconto. Anche la soggettiva del demone che attraversa la foresta, che cita una delle più famose scene del film di Raimi, è elemento residuale, collocato in modo piuttosto artificioso in un contesto a cui non appartiene. Perché ne La Casa di Alvarez succede sempre qualcosa. Lo spettatore non ha neanche il tempo di abbozzare un pensiero sui possibili avvenimenti futuri che tutto è già accaduto, un tour de force che può essere, per alcuni, la forma di entertainment definitiva, libera da ogni spazio interstiziale di pensiero, se pur primitivo. Per altri, meno temprati, una masochistica prova di resistenza.
Alvarez spinge quindi alle estreme conseguenze la spettacolarizzazione dell’orrore di cui Raimi è antesignano, ma senza condividerne l’ironia (nonostante alcune scelte più o meno consapevolmente ridicole, come l’ostinazione con cui David, lo scialbissimo Shiloh Fernandez, cerca di medicare ferite mortali con lo scotch da pacchi) e senza condividerne, in particolar modo, la totale mancanza di sottotesto psicologico, sociale o culturale. Qui invece il sottotesto c’è eccome e, volente o nolente, riveste il film dell’alone reazionario e della valenza metaforica ed esemplare di certo horror punitivo: la famiglia disfunzionale, il figlio egoista e la figlia peccatrice che prende su di sé l’onere dell’espiazione, attraverso un percorso di passione che, passando per i più abietti stadi del disfacimento di sé e per la morte rituale purificatrice, arriva alla resurrezione e alla liberazione da ogni demone.
Groovy? Non tanto, Ash. Questo Evil Dead (non a caso senza The) è uno spirito maligno tra tanti, ripugnante quanto poco spaventoso e durevole. Già rimosso, dalla storia e dalla mente, nel tempo di una breve pioggia di sangue.
Scritto da Barbara Nazzari.
![]()
Continua a errare su Facebook e Twitter per essere sempre aggiornato sulle recensioni e gli articoli del sito.
| Antonio M. | Edoardo P. | Giacomo B. | ||
| 4 | 6 | 5 |














































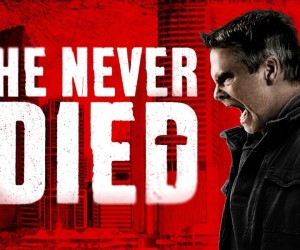






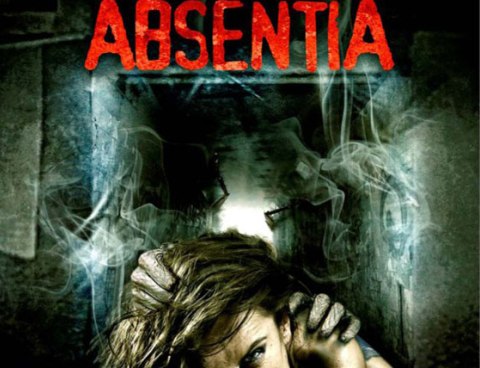
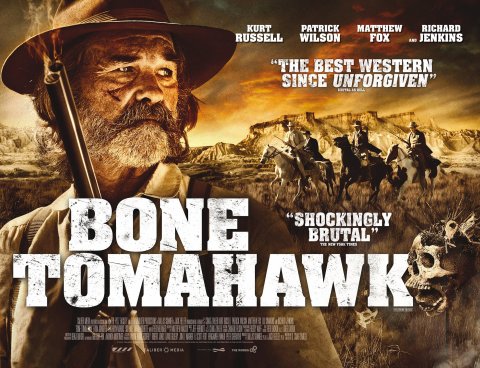





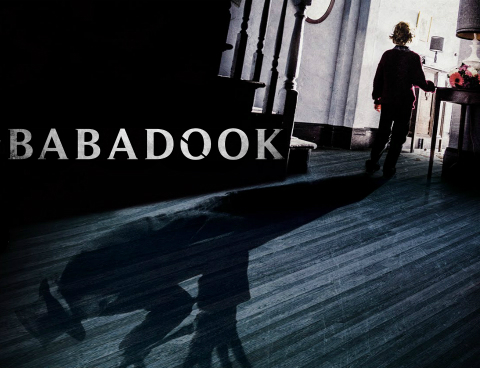
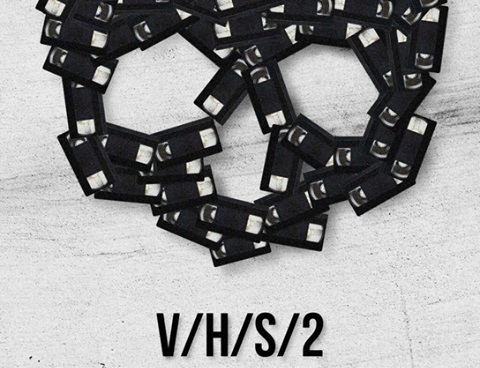































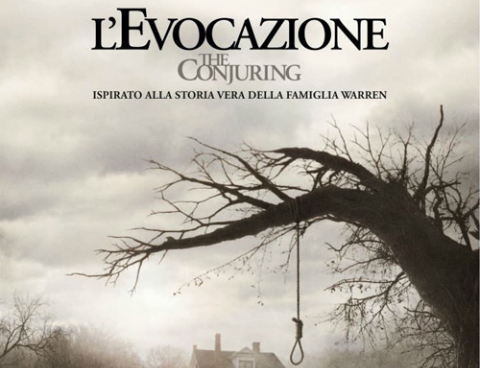
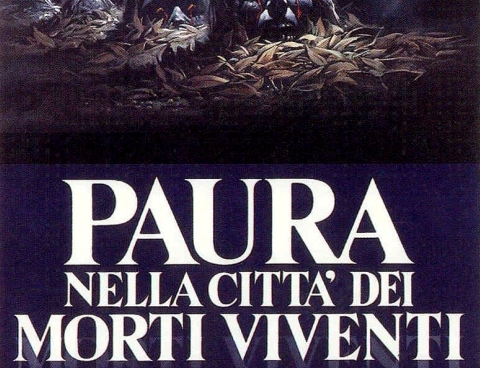







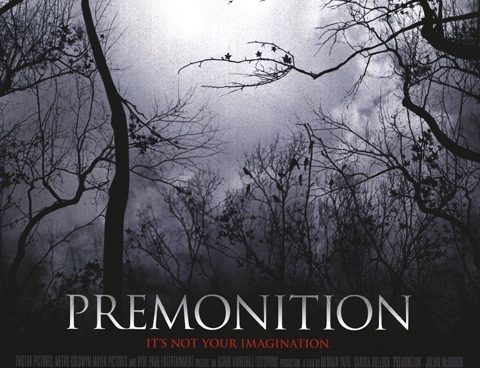


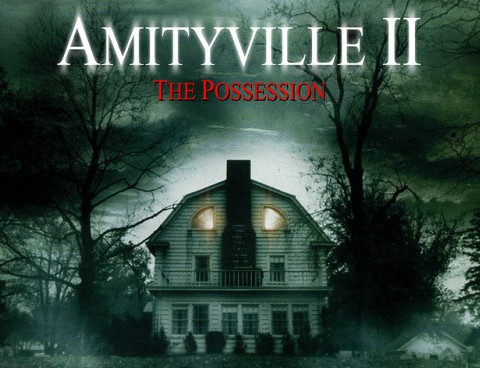




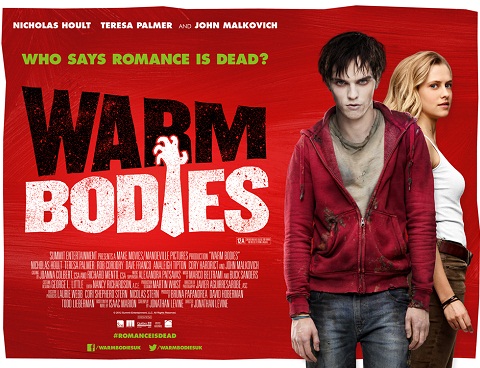






Remake buonissimo un po’ troppa carne al fuoco ma intrattiene alla grande.Effetti gore notevoli.Il film di Raimi è ben altra roba, però si difende benissimo.Le stroncature(non poche) che mi è capitato di leggere mi sono sembrate esagerate.Un film di genere onesto ne più ne meno. VOTO 4/5