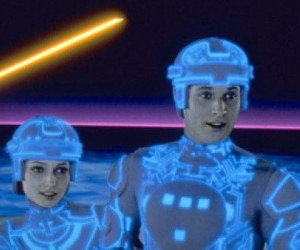C’era una volta… Lars Von Trier: Antichrist
Era il 2011, eppure sembra ieri che Lars von Trier esponeva, in quel di Cannes, quelle sciagurate considerazioni storico-politiche che l’avrebbero di lì a poco portato a guadagnarsi l’appellativo di persona non grata in zona Croisette. Intendiamoci: non è certo il primo atto dissidente che ha portato il simpatico regista tracimante ego (e in quel “von” posticcio c’è già tutto il personaggio) all’attenzione degli addetti ai lavori, piuttosto il primo che l’ha posto sotto altri tipi di riflettori. Che ha dato il via, insomma, a un processo di banalizzazione della sua figura, al tentativo di macchiettizzare, confezionare e – perché no – commercializzare una personalità tanto geniale quanto stravagante e disturbata.
Prima delle dissertazioni parapornografiche dei recentissimi Nymphomaniac, prima ancora delle riflessioni apocalittiche che muovevano Melancholia, nell’ancor più lontano 2009 Lars von Trier aveva già avuto modo di scandalizzare le platee (festivaliere e non) con Antichrist, film che, visto in retrospettiva, ben si sposa con la “nuova” figura bassamente cucita attorno al regista danese. Eppure Antichrist contiene spunti già presenti in larghe porzioni della filmografia passata: tematiche già care al regista, trasferite magari in atmosfere più fosche e declinate, questo sì, con stilemi relativamente nuovi, più vicini a certe tendenze del cinema horror che a quello che si potrebbe comodamente definire cinema d’autore. A quelle ossessioni se ne sono poi aggiunte altre, ben più urgenti e compulsive, sgradevole lascito del periodo di depressione dal quale lo stesso regista stava uscendo proprio durante le fasi di scrittura e ripresa.
La storia, presto detta, si esaurisce nel primo dei cinque atti che scandiscono il film, allorquando ci vengono presentati – con immagini al ralenti in uno scolorito bianco e nero pataccone accompagnato dalla celebre Lascia ch’io pianga del Rinaldo – i due protagonisti, intenti a consumare un atto sessuale. Il figlio di pochi anni, momentaneamente perso di vista, vaga per la casa fino a cadere da una finestra. Poco tempo dopo, lui (Willem Dafoe), psicoterapeuta, cercherà di curare la depressione di lei (Charlotte Gainsbourg) portandola in un cottage in montagna.
Su questo canovaccio si dipaneranno i successivi quattro atti (dai titoli opportunamente minacciosi: “dolore”, “pena”, “disperazione”, più un epilogo). Ed è proprio sullo sfondo di questo bosco, capace di farsi prima fisico, quindi simbolico ed eventualmente poetico che il film comincia a disvelare la sua vera natura. All’itinerario personale, spirituale e, perché no, pure sessuale dei due protagonisti, alla sofferta contemplazione e al tentativo di ristabilire un rapporto con l’ordine naturale delle cose (la Natura stessa?), si affianca una componente esoterica, che si fa lentamente spazio prima di determinare il tono del film e del dispiegarsi degli eventi. Non è nostro compito mettere in discussione la validità o l’opportunità di simili digressioni: ben più discutibile ci sembra la scelta dei significanti (dalla trinità animalesca alle iconcine d’epoca di Belzebù) e la martellante proposta per accumulo degli stessi, capace di condurre il film lontano dai lidi allegorici cui aspirava per portarlo sul ben più prosaico campo della pernacchia.
Lungo una degenerazione grandguignolesca capace di valicare sia i limiti del risibile (la scena della volpe che, nutrendosi di sé stessa, dice a un Dafoe attonito “il caos regna” avrebbe fatto esplodere il web 2.0) che del sopportabile, si nasconde quella che è l’anima più vera del film e, di riflesso, del suo autore. Perché se è vero che Lars von Trier ha da sempre amato impossessarsi dello spettatore, conducendolo – lecitamente o meno – negli abissi delle proprie trame e dei sentimenti, Antichrist trasmette l’idea di un autore bloccato, costretto a confrontarsi con angosce più grandi di lui. Furbo o sincero, cinico o generoso, il regista sembra aver utilizzato il suo film, il cinema e, per certi versi, noi spettatori come mezzo per esorcizzare le proprie paure. Da parte nostra, troviamo difficile persino giudicare quello che, pur rimanendo – al netto di alcune, felici intuizioni – un film sbagliato, trasmette una sincerità e un’intimità quasi imbarazzante; e se in altre occasioni non abbiamo mancato di pungolare Lars von Trier per le più svariate ragioni, di fronte a quello è il suo corpo flaccido, nudo e tumefatto facciamo sinceramente fatica a infierire.
![]()
Scritto da Giacomo Ferigioni.
Continua a errare su Facebook e Twitter per essere sempre aggiornato sulle recensioni e gli articoli del sito.
| Chiara C. | Edoardo P. | Sara M. | ||
| 4 | 5 | 5 |